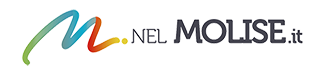LARINO. Terza tappa della tetralogia dello spirito dell’amico e studioso Pino Miscione che questa volta ci porta nella città dei papi. E lo fa partendo comunque da Larino, dalla sua città dove, era la primavera del 1978, partì alla volta della Capitale. La sua è una disamina sugli ultimi successori sul soglio di Pietro.
“Il pullman della ditta Mirco che in quella primavera del ’78 ci portava a Roma per la gita che segnava l’addio alla scuola elementare deviò dal percorso prefissato e transitò per via Fani. L’autista decelerò vistosamente e comunicò con tono grave, a noi che avevamo incrociato la vicenda nelle nostre famiglie e a scuola: «Vedete? È successo qui». Satana ci era transitato pure lui, solo qualche settimana prima: Moro rapito, la sua scorta annientata nel sangue. La nostra prima volta nella Città Eterna – noi della quinta classe – fu segnata da questo sconvolgente fatto criminoso. Poi il pullman ci scaricò in piazza San Pietro, la nostra vera destinazione di quella grigia mattinata.
Sul trono del Principe degli Apostoli era assiso, da tempo scomodamente e nel suo occiduo passaggio, un Pontefice oggi poco compreso e ancor meno amato, che di Moro era amico. Malgrado l’appello agli “uomini delle Brigate rosse”, che lui stesso volle promuovere contro ogni consuetudine e superando resistenze plurime, il Papa e l’uomo di Stato mai più si ritrovarono in questo mondo: «Ed ora le nostre labbra, chiuse come da un enorme ostacolo, simile alla grossa pietra rotolata all’ingresso del sepolcro di Cristo, vogliono aprirsi ad esprimere il “De profundis” il grido, il pianto dell’ineffabile dolore con cui la tragedia presente soffoca la nostra voce». La preghiera del Pontefice per Moro – il corpo assente –, elevata con voce stenta, tremula, a tratti quasi singultante, sotto il ciborio della Cattedrale di Roma nel giorno in cui la Chiesa fa memoria di Nostra Signora di Fatima. Pietro è come tutti, e più di tutti, indotto in tentazione, messo alla prova.
Questo antico gioco tra Cielo e Inferno, Satana che scatena i suoi assalti al Vicario di Cristo, seguita sin da quella notte atra di acuto dolore nella quale Pietro disconobbe il suo Signore che andava a morire sulla Croce: «Prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte» rammentò per amaramente ravvedersi.
Paolo VI non sopravvisse a lungo a quell’ulteriore insulto demoniaco. Padre Carlo Cremona, che fu suo stretto coadiutore, confiderà anni dopo che durante quella vicenda «la sua angoscia venne crescendo giorno dopo giorno. … Tenebre e tempesta, l’impotenza di fronte a un Satana che nessuno riesce a legare. … Irrazionalità e ineluttabilità della prova che schiaccia l’innocente».
Il Papa aveva pubblicamente denunciato colui che abiettamente gioca coi destini dell’uomo già alcuni anni prima: «Si direbbe che da qualche fessura è entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio. … Crediamo in qualcosa di preternaturale venuto nel mondo proprio per turbare, per impedire che la Chiesa prorompa nell’inno della gioia».
Era tempo di vacanze estive quando quel Pontefice fu infine liberato dal suo giogo e si congedò da questo mondo. E ne venne un altro, mite pasta d’uomo, dal sorriso timido ma dal temperamento risoluto che, attaccando ancora una volta la sua battaglia contro il demonio – quest’essere prevaricatore e superbo, dal copione ridondante di nequizia alquanto ristretto e prevedibile – consumò la sua fulminea rivalsa contro il bianco Padre fino a toglierlo di mezzo.
E ne chiamarono un altro ancora «di un Paese lontano», che si sporse dalla loggia quando il denso fumo bianco d’obbligo si era disfatto negli esili refoli di ottobre, ed ero già approdato alle medie: «Se mi sbaglio mi corrigerete». Ma Satana non si diede per vinto ed allestì il suo spettacolo spettrale senza porre un tetto al suo budget, trascinando stavolta nel suo gioco luciferino i media, le forze dell’ordine, la magistratura, non prima di aver sparso per il campo false piste che conducessero a ricercare i mandanti del delitto il più lontano possibile. Nostra Signora di Fatima non lo consentì quella volta, e al Papa polacco fu chiesto di caricarsi della Croce del Signore per lungo tempo ancora: spossato, sempre più incurvato, ridotto a corpo tremolante che andava disfacendosi sotto lo sguardo sgomento dei fedeli. E quando al calar del mio trentennio gli fu concesso di porre fine al suo martirio, mi aggregai alla fila interminabile e passai una notte all’addiaccio per rendergli l’ultimo saluto. «Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell’ubbidienza verso il Nostro Signore e nella fiducia totale alla sua Madre, Madonna Santissima» aveva detto con malcerto eloquio italico quando ero un ragazzo del primo mese di prima media. “Paura” della nomina, del macigno che piomba sulla vita di un uomo che diventa Pietro.
«Pietro, mi ami tu più di costoro?». Gli chiese il Signore risorto sulle rive del mare di Tiberiade. Glielo chiese per due volte, e una terza si limitò a domandargli se Gli “volesse bene”. L’evangelista pone in evidenza l’uso di due verbi greci difformi – agapào, filèo –; e il primo soltanto fa diretto riferimento al perfetto amore che ha origine divina: «Li amò sino alla fine»: salendo sulla Croce per dare la propria vita. Il pegno di tale sublime, infinito amore è appunto l’Eucaristia, vera agàpe. L’uomo, anche il Principe degli Apostoli, è capace pur sempre di un amore imperfetto, perché umano e dunque caduco per l’erranza dei nostri primi genitori in Eden. L’amore di Cristo per ogni uomo è invece rivestito di perfezione; amore divino immune da ogni umana caduta. Esso si posa su ciascuno che degnamente rivive l’esperienza del discepolo che Lui “amava”, specialmente quando verrà l’ora del tradimento, della persecuzione e della Croce. Pietro «mi vuoi bene, dunque?». «Signore, Tu conosci tutto; Tu sai che ti voglio bene». «Pasci le mie pecore».
Ubbidiente, compreso nel suo gravoso mandato: provenendo da Antiochia, dove pose la sua prima cattedra – in questa città i seguaci di Cristo furon chiamati per la prima volta “cristiani” –, Pietro giunse a Roma nell’anno 42, dove ebbe anche modo di trasmettere al suo collaboratore Marco un vangelo. Nella sua prima epistola, indirizzata ai cristiani dell’Asia minore, denomina la capitale dell’Impero “Babilonia”: forse un modo per non far sapere dove realmente si trovasse. La testimonianza della sua presenza nell’Urbe è certa e si fonda su molteplici passi di Ireneo di Lione, Papia di Gerapoli e Clemente di Alessandria, così come ce li riporta Eusebio di Cesarea nella sua Storia ecclesiastica.
Ma pendeva pur sempre il vecchio gioco tra Cielo e Inferno: Tertulliano riferisce che, pervenuta all’imperatore Tiberio una relazione sui seguaci del Nazareno messa a punto da Pilato, la presentò al Senato per ottenere il riconoscimento di Cristo come Dio – uno dei tanti, tuttavia –; ma ricevuto un netto rifiuto ne derivò che il nuovo credo diveniva a tutti gli effetti superstitio illicita. L’Imperatore pose tuttavia un veto a che una persecuzione contro gli appartenenti alla Via di Cristo fosse avviata: il primo catèchon della storia cristiana.
Questo potere frenante venne rimosso dopo l’incendio dell’Urbe dell’estate del 64, quando Nerone – lui sì responsabile diretto – si decise ad incolpare i Cristiani del disastro. La prima vittima illustre fu l’apostolo Paolo, da Gerusalemme giunto a Roma già nell’anno 56, avendo appellato a Cesare in qualità di cittadino romano. Ai primi prodromi della brutale persecuzione venne nuovamente processato e, alle Auqæ Salviæ sulla Via Laurentina, gli venne mozzata la testa. Il suo corpo fu deposto invece sulla Via Ostiense, dove in epoca costantiniana venne innalzata una piccola basilica, molto ingrandita nei secoli a venire.
Volendo emulare in tutto il suo Signore, Pietro, che civis romanus non era e non poteva accedere alla rapida decollazione, accolse il martirio di croce, ma con la testa volta alla terra. «Quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». La cronologia più accreditata fissa l’evento all’ottobre del 64.
Le sue reliquie, avvenuto il sacrificio cruento all’interno del Circo Vaticano dove Nerone amava veder allestiti ludi dei quali godere personalmente – lui e la sua ristretta cricca –, vennero tumulate alla bell’e meglio nella vicina necropoli vaticana, un cimitero piuttosto esteso adoperato indistintamente da cristiani e pagani. Agli inizi del IV secolo, assurto il Cristianesimo a religione trionfante, l’esteso sepolcreto venne parzialmente demolito, interrato e spianato – atto in sé sacrilego e tuttavia concesso a Costantino imperatore – per innalzarvi una grandiosa basilica, che avesse come pietra fondante la memoria fisica del Pescatore di Betsaida: et super hanc petram ædificabo ecclesiam meam. Fatto tuttavia materiale, seppure di cruciale rilevanza.
Roma amor: così comincia la storia d’amore tra la Città Eterna e il popolo di Dio. Popolo sacerdotale, profetico e regale del quale non posso che far parte usque ad finem. Compreso in questo sentimento che ci è infuso con l’acqua del battesimo, mi rivedo ora scivolare sui sampietrini della Via Appia antica, mentre monto una bicicletta presa a nolo. Sporadiche automobili molestano il mio quieto andare su queste pietre sconnesse ma ormai tanto consuete. Addosso il sellino a un tronco di pino e mi accingo a farmi guidare all’interno delle catacombe di San Sebastiano, dove in origine sorgeva la basilica Apostolorum, eretta nel IV secolo cristiano sulle memorie martiriali degli Apostoli. Questo era l’antico luogo ad catacumbas – “presso le cavità” che in questo sito abbondavano –, nel quale agli albori della persecuzione di Valeriano del 258, temendo un trafugamento per rappresaglia, le ossa dei due Santi vennero provvisoriamente traslate e messe al sicuro. Ancora ben riconoscibili i graffiti devozionali, con le invocazioni ai due santi nomi, incisi alla meglio su una parete dell’edicola che proteggeva i loro resti mortali. Inforco ancora la mia bici, faccio il percorso a ritroso per ricondurla dove l’ho presa, e la mia nuova statio è stavolta la chiesa del “Domine quo vadis”. La leggenda agiografica è nota: «Domine, quo vadis?» – Signore, dove vai? Così Pietro, fuggitivo per stanchezza o per paura, al Maestro. E Lui al suo Primo Vicario in terra: «Venio Romam iterum crucifigi» – Vengo a Roma per farmi crocifiggere di nuovo. Al posto tuo, s’intende; tu che vorresti tornartene alla tua casa, dalla tua famiglia: fine corsa.
Qualcuno – molto sbrigativamente, reputo – ha voluto vedere nell’atto della “rinuncia” del papa Benedetto XVI un gesto equipollente: il Pastore che braccato dal maligno si dà alla fuga abbandonando gli agnelli alla voracità dei lupi. «Non si scende dalla Croce» esclamò un precipitoso cardinale polacco. Ma io e con me tanti altri non prestiamo fede a questa comoda versione dei fatti. Del resto il Papa bavarese, uomo di curia di lungo corso che non ignorava talune occulte dinamiche dell’apparato vaticano, era ben conscio della minaccia esiziale: «Pregate per me perché io non fugga, per paura, davanti ai lupi». E quando realmente quei lupi tentarono più volte di azzannarlo perché si risolvesse a lasciare alla sua tragica sorte l’intero gregge che Cristo gli aveva affidato, con decisione ispirata, accorta, lungimirante pronunciò quelle impegnative, inaudite parole: «Sedes Sancti Petri vacet»: vacet, è vuota, libera, ha ricostruito un acuto giornalista. La battaglia finale, quella vera e decisiva, si conduce altrove.
«Senza una fede un popolo non ascende e non vive. Signore, quale fede sarà? Questa interrogazione ci riempie di timore per il nostro domani» disse un tormentato Montini alla vigilia del suo Papato. Dopo qualche decennio non mancano avvisaglie più che espressive: grande festa in Vaticano, nell’ottobre di qualche anno passato: un prologo nei Giardini, dove ci si prosterna, si prega e si adora qualcosa che non ha nulla di cristiano. Avanza il corteo composto da vescovi e cardinali con il loro codazzo di curiali, lungo la fastosa navata della basilica intitolata al Principe degli Apostoli, mentre alcuni portatori sorreggono sulle loro spalle un idolo andino con le fattezze di una donna panciuta alla quale nel tetro evo precolombiano si offrivano sacrifici con spargimento di sangue, e ancora adesso in tanti luoghi del Sudamerica la si onora. Satana ha infine messo a segno il suo colpo da maestro – apostasia e idolatria – e si accoda al seguito sacrilego, al quale avrebbe diritto di fare da battistrada. La fessura che nel ’72 era avvertita come tale ora si è aperta in uno squarcio smisurato, e i diavoli scorrazzano nel tempio di Dio come i bersaglieri a Porta Pia.
Cosa stanno costruendo questi nuovi occupanti dell’Urbe, gli ennesimi e probabilmente quelli terminali, è sotto gli occhi di tutti. Risuona sotto la Cupola di Michelangelo il grave monito della Madre della Chiesa alla Salette: «Roma perderà la fede … ». Si replicano gli allarmi di Leone XIII: «Lì dove fu istituita la Sede del beatissimo Pietro e la Cattedra della Verità, hanno posto il trono …». Tutto ciò è opera del diavolo. Eppure, c’è addirittura più di qualcuno, anche tra i chierici, perfino d’ufficio altissimo, che non crede alla repellente creatura del male: Satana non esiste; un po’ come “non esiste” la nostra piccola terra. Piuttosto singolare che taluni scontri escatologici debbano conflagrare tra due “non esistenze” o presunte tali.
Ho iniziato a vivere questo testo dolente che ero un bambino delle elementari, ed ora ho più di cinquant’anni. Non torno a Roma dal 27 febbraio del 2013: l’ultima benedizione del suo Vescovo nella grande piazza. Poi la macchina varcò il casello autostradale, ed era notte. Non sono più tornato. Attendo, come molti, l’alba.
Pino Miscione
(foto tratte dal web)
Nota – Alcune notizie su Paolo VI sono tratte da “Adesso viene la notte” di Ferruccio Parazzoli. L’acuto giornalista di cui si parla è Andrea Cionci.