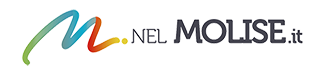LARINO. Dumas e San Pardo. Con piacere pubblichiamo l’intervento dello studioso Pino Miscione che ci parla della vera salvezza partendo da quel connubio letterario che lega la morte della San Felice proprio alla festa in onore del santo patrono di Larino.
“Scrisse molto Dumas, e non sempre ad eccelsi livelli. Sto parlando di Alexandre Dumas padre, e non del figlio, perché pur essendo uguali nel nome non furono della stessa sostanza letteraria né il figlio eguagliò il padre in quanto a fama e fortuna. Dumas padre era un avventuriero e un bon vivant; e si sa, per vivere bene è utile avere un po’ d’argento più del bastevole. E allora scrisse in abbondanza, spesso pubblicando a puntate sulle riviste parigine i suoi romanzi e feuilletons.
Una delle prime sue opere che di solito si legge da ragazzini, ricevuta in dono per qualche occasione particolare che ai più non tornerà alla memoria, è Il conte di Montecristo. Conosciamo la storia: all’incolpevole Edmond Dantès, per invidia di carriera e d’amore, viene teso un tranello che lo fa condannare all’ergastolo da scontare in una cella dello château d’If, al largo di Marsiglia. Dopo lunghi anni di prigionia, dal compagno di cella abate Faria viene a conoscenza dell’esistenza di un tesoro nell’isola di Montecristo, nell’Arcipelago toscano. Riuscito finalmente ad evadere e trovato il tesoro che esisteva per davvero, ritorna in patria e consuma la sua vendetta sotto le mentite spoglie di Conte di Montecristo e di diversi altri personaggi.
Dumas lo pubblicò nel 1844 e fu un grandissimo successo. Vent’anni dopo, quando risiedeva già da qualche anno a Napoli, e con qualche carica di rilievo ricevuta da Garibaldi in persona, suo amico e confratello massone al cui seguito s’era unito nella spregiudicata epopea dei Mille, diede invece alle stampe un lungo romanzo d’appendice pubblicato a puntate a Napoli e a Parigi, ambientato nel Meridione d’Italia: La San Felice.

Racconta, romanzando ma non troppo, ciò che nel Regno di Napoli suscitò il vento rivoluzionario che furioso spirava dalla Francia, fino a costringere il re Borbone e la sua corte a fuggire nella capitale dell’altro Regno, Palermo. Col diretto sostegno francese, a Napoli presero il potere i rivoluzionari giacobini, quasi tutti appartenenti alla nobiltà e agli alti ceti. Ma l’esperimento ebbe vita breve ed effimera: dalla Calabria, il cardinale Ruffo riuscì a combinare una variegata soldatesca di contadini e popolani che andarono a formare l’ “Esercito della Santa Fede” il quale, grazie anche al sostegno di Nelson e della sua marina, riuscì a riprendere il potere. La repressione fu durissima.

Il nostro Vincenzo Cuoco, talvolta citato nel romanzo, che in quell’epopea rivoluzionaria fu coinvolto e che di essa fu storico severo, riporta gli avvenimenti con acume critico nel suo Saggio storico sulla Rivoluzione napoletana, la cui prima edizione uscì a Milano in forma anonima nel 1801. Mal congegnata ed utopistica Rivoluzione partenopea, totalmente sconnessa dalle vere istanze popolari, tanto che il Cuoco stesso non lesinava critiche e appunti negativi: le idee della rivoluzione di Napoli avrebbero potuto esser popolari ove si avesse voluto trarle dal fondo istesso della nazione. Tratte da una costituzione straniera, erano lontanissime dalla nostra, fondate sopra massime troppo astratte erano lontanissime da’ sensi, e quel ch’è più, si aggiungevano ad esse, come leggi, tutti gli usi, tutt’i capricci e talora tutt’i difetti, di un altro popolo, lontanissimi dai nostri difetti, da’ nostri capricci, dagli usi nostri.
In questa cornice storica s’inquadra la vicenda affettiva tra Luisa de Molina Sanfelice – gentildonna napoletana realmente esistita, filogiacobina per caso più che per convinzione – e il suo amante Salvato Palmieri, un giovane rivoluzionario italo-francese uscito invece dalla penna di Dumas. Personaggio maschile principale che della sua origine spiega lui stesso nell’ottavo capitolo, intitolato significativamente “Il diritto di asilo”: «Notre famille habitait de temps immémoral la ville de Larino, dans la province de Molise: elle avait nom Maggio-Palmieri». Padre chirurgo formatosi a Napoli – riassumo a vantaggio del lettore –, innamorato della sua Angiolina Ferri, che il conte di Molise insidiava pretendendo l’indicibile: troppo. Scampata a un rapimento, la donna si rifugiò infine nel palazzo arcivescovile – vacante il seggio –, che godeva del diritto d’asilo, al quale gli sgherri del Conte fecero un presidio serrato. Ma Giuseppe riuscì a entrarvi comunque e a contrarre matrimonio con la sua sposa promessa nella cappella del Vescovo, celebrante il vicario.
«Ennuyé de sa captivité, Giuseppe Palmieri résolut un jour d’en finir avec son persécuteur …»: presso la fontana di San Pardo – ma le fonti storiche di cui diremo riportano che il fattaccio avvenne invece nei paraggi del convento dei Cappuccini – il Palmieri, travestito da monaco, prima ferì il Conte, poi lo invitò a duello che, rifiutato con sdegno, si tramutò in omicidio. E di nuovo rinserrato in quello che qualche vecchia donna di famiglia chiamava ‘u palazze du ‘ccellendìsseme.
«On arriva au 26 mai, jour où l’on célèbre à Larino la fête de saint Pardo, … patrono della città. In quel giorno – scrive Dumas – aveva luogo una grande processione: i contadini ornavano i loro carri di ghirlande e di fiori, di drappi e banderuole di tutti i colori; essi vi attaccavano dei buoi dalle corna dorate e li bardavano con nastri variopinti. Questi carri seguono la processione che porta in giro per la città il busto del Santo protettore, accompagnato da tutta la popolazione di Larino e dei villaggi vicini, che canta inni di lode al Santo. Questa processione, per entrare nella Cattedrale, doveva passare innanzi al palazzo arcivescovile ove si erano rifugiati i due giovani sposi. Al momento in cui la processione si fermò sulla grande piazza della cittadina – è evidente che l’écrivain non la vide mai – cantando e danzando attorno al carro imbandierato, Angiolina, credendosi sicura in quel momento in cui tutte le menti dovevano essere rivolte al Cielo, si accostò ad una finestra». E proprio allora – sunteggio il resto – il fratello del Conte le sparò addosso. Accorse il marito, ma «tout fuit inutile. Elle était morte!». Vedendo il ventre della morta agitarsi, il fresco vedovo comprese: mise mano al bisturi ed estrasse il corpo del bambino, ch’era vivo. Con quel fardello Palmieri attraversò la piazza e stecchì sul colpo due armigeri che avevano tentato di stopparlo. Superato a nuoto il Biferno (!), giunse a Manfredonia, e da quel porto un vascello dalmata lo condusse a Trieste. «L’enfant, c’était moi». Dopo avergli fatto solennemente dichiarare di voler vendicare pure quella sua seconda madre ch’era la patria, Dumas chiude il capitolo larinate.
Questo è ciò che ci tramanda lo scrittore francese a proposito della festa di San Pardo e dell’agguato al Conte; fatto realmente accaduto a Larino, ma ben prima: 1° maggio 1679, imboscata al duca Francesco Carafa per l’identico motivo. Come il prolifico scrittore sia venuto a conoscenza della congiura larinate di fine XVII secolo, difficile a dirsi.
Ammazzarono Angiolina il 26 maggio, in piena festa patronale di San Pardo, vescovo e confessore. Urge chiarire che con quest’ultimo termine – confessor, ὀμολογητής (omologhētḕs) – si voleva qualificare chi, sottoposto a processo e a tortura, confessava la propria fede, pur evitando la morte. Costui fu Pardo vescovo, che le due Vite ci riportano essere stato a lungo perseguitato dai lupi introdottisi nel sacro ovile. Un’evenienza calamitosa che talvolta ritorna nella storia della Chiesa, e per come la vedo io, mai in modo così nefando come in questo nostro tempo.
Anche per questo, c’è in atto un tentativo subdolo di fare di questo nostro Patrono solamente un personaggio di spicciola cronaca, peraltro terra terra o per meglio dire umano-terrena; buono per una festa che taluni giudicano fin troppo chiassosa, che per i noti motivi sanitari è bandita per la seconda volta. Da qualche tempo stanno architettando di rinchiuderci in una immateriale gabbia, che però rischia di farsi sempre più concreta; e la maschera che da ormai un anno ci copre le fattezze perfino all’aria aperta – “maschera di ferro” come in quell’altro scritto di Dumas, seppur di floscia pezza – a me pare, quando in certi contesti non è affatto necessaria, il segno della nostra sottomissione: vietato dissentire; irresponsabile chi lo fa, ovvero “negazionista”.
Certe rigidità di pensiero furono d’altronde alla radice della Rivoluzione francese e parimenti del suo epilogo inglorioso; decapitati infine pure i suoi intransigenti fautori: la Révolution dévore ses propres enfants. Come cattolico, non potrei certamente avere in simpatia chi ha mandato alla ghigliottina anche e innanzitutto preti, suore, religiosi e gente del popolo, spesso solamente per il fatto che credevano nel Dio fattosi carne nel Bambino di Betlemme: “negavano” i valori della Rivoluzione. Ma nemmeno posso ammettere che si condanni alla pena capitale senza processo o mediante esecuzioni sommarie, venendo meno alla parola data, come capitò ai soccombenti rivoltosi di Napoli; né potrei avere un’opinione favorevole di un re duro di cuore che rifiuta moderazione. Nondimeno, per quello che potrà essere il mio ruolo, già mi vedo reclutato di diritto tra quelli di questa finale epopea vandeana, come le decine di migliaia che fieramente andarono incontro alla morte per difendere i valori cristiani in cui credevano. Quanti morti in questa storia!

L’ultima moritura che andiamo a visitare è lei, la protagonista del nostro romanzo, verso la quale re Ferdinando IV rifiutò più volte di usare quella clemenza che pur gli consigliavano. Mi vedo perciò salire ancora una volta il lindo scalone della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, dove sta il quadro di Gioacchino Toma, quello che meglio conosco, non avendo memoria della tela gemella di Capodimonte: eccola qui la Sanfelice!
Immersa in un dipinto dove non c’è ombra della tragedia che incombe. Elegia dell’isolamento mirabilmente ricreato in un ritratto a olio, che riproduce la calma attesa della condanna a morte anglo-borbonica in tenuissime ed insolite gamme cromatiche di grigi, azzurri e bruni. La cornice del quadro va a formare le uni- che sbarre che la tengono reclusa e che le impediscono di fuggire, seppur ci sembri svogliata a farlo, verso di noi che a lei ci appressiamo. Non diciamo a questa donna, per non destarla né dalla sua quiete apparente né dal suo accurato lavoro al quale è intenta, in quale modo orrendo il boia le darà il colpo di grazia, sgozzandola col suo coltellaccio di servizio al terzo tentativo perché un colpo di fucile partito per errore da un armigero, impaurito dalla folla stanca di sangue, distoglierà dal suo precipitare il colpo secco della sua mannaia, finita a fracassarle le spalle.
Questo non glielo diciamo: serenamente la condannata a morte è fissa sul suo ricamo. Oggi la si vedrebbe armeggiare col suo telefonino come fanno tanti di noi; rinchiusi in una dimensione che ci vede autoreclusi entro una immateriale casa di pena: morti che credono di essere vivi, siamo. Per dare un significato a questa vita diventata così arida c’infossiamo in un’esistenza digitale parallela che, quanto più sarà diversa da quella reale, tanto più ci sembrerà vita vera, e non, com’è difatti, un suo esangue sembiante.
Tutto ciò si mostra sempre più come un mero, disperante “sopravvivere”: stanchi, depressi, demotivati, rassegnati all’inevitabile; prova che tuttavia il vero credente affronta con consapevolezza e determinazione. Eppure non si può sempre subire ciò che appare palesemente irragionevole: bandite le processioni, ma consentiti i raduni per la vittoria del campionato di calcio; bar e ristoranti sempre aperti sulle autostrade o per deputati e senatori, serrati o sottoposti a snervanti controlli nei centri urbani; coprifuoco in tempo di pace, peraltro non ammesso dall’ordinamento repubblicano. Allarma in particolare la condizione in cui si trovano ragazzi e bambini in età di scuola: che uomini saranno domani? E che domani avranno?
Faccio fatica ad ascoltare in qualche predica alla quale pur mi capita di esser presente, un’invocazione al Cielo affinché si ottenga la vera guarigione che ci è necessaria, mentre la “pandemia” sarebbe – stando a quel che si ascolta anche da elevatissime, ma ahimè screditatissime cattedre – il risultato dell’offesa alla “Madre terra”, ed è invece vietato confessare apertamente un assunto teologico mai messo in discussione in altre epoche, e cioè che “Dio castiga”; e quando castiga, quando permette il male, lo fa per incoraggiare una correzione e stimolare una purificazione (castus agĕre significa appunto questo). Non ho finora ancora udito, nella cosiddetta “preghiera dei fedeli”, o in una qualsiasi omelia nostrana, un’invocazione all’Altissimo affinché ci liberi da questo modo di vivere disumano: l’Italia, l’Europa, il mondo intero trasformati in un globale gulag dove non è permesso alcun dissenso.
Mentre si apprende che addirittura in alcune chiese italiane viene distribuito un kit per le vaccinazioni. L’elisir di lunga vita, che garantirebbe una “salvezza” tutta umana, prende il posto dell’unico “farmaco dell’immortalità” – così lo chiamava Sant’Ignazio di Antiochia – che ci è necessario: la Santa Eucaristia, la quale d’altra parte viene distribuita nei banchi, solo sul palmo delle mani, come se il Corpo di Cristo possa essere veicolo di contagio, e no già di salvezza eterna. Alle possibili obiezioni, rispondo che in tempi di pestilenza – quella vera – si adoperavano le pinze eucaristiche.
Ci si illude di poter venir fuori da questo disperante stato di cose, che si configura come una vera e propria riprogettazione dell’umana esistenza, per via esclusivamente sanitaria, mentre è chiaro che la situazione spiacevolissima è epocale e la disumanizzante manovra cha ad essa punta è avvolgente e va ad intaccare pesantemente ogni comparto del vivere civile: le libertà personali, l’economia, l’istruzione, l’informazione, il lavoro, la giustizia, la famiglia, il culto. Mentre, a chi ha una visione teologica delle cose del mondo come nel mio caso, appare chiaro che da essa si viene fuori necessariamente per altre vie.
Da un anno e passa alle feste comandate – Natale e Pasqua particolarmente – si fa di tutto per relegare, credo più del necessario, la fede cattolica, la nostra stessa esistenza su un’isola inabitata: al gabbio come quell’incolpevole Edmond Dantès rinchiuso nello château d’If, o peggio ancora come donna Luisa de Molina Sanfelice in attesa dell’esecuzione della sua condanna capitale. Ma il cristiano deve sempre ricordarsi che è libero anche quando è in catene. La storia è lunga: il protomartire Stefano, Pietro e Giovanni, Paolo e Sila, Tommaso Moro e Massimiliano Kolbe, e i nostri Primiano, Firmiano e Casto; e fors’anche Pardo, vescovo e confessore di Cristo, da qualche lacerto incognito della sua biografia potrebbe saltar fuori che fu messo ai ferri e lasciato a marcire in qualche gattabuia. Confessore di Cristo, della sua propria limpida fede, e non già “confessore” di qualche malefatta che il cattolico incamminatosi sulle sue orme spirituali dovrebbe inequivocabilmente ammettere. Altri, e in altro loco, sono i colpevoli.
Il tiranno – oramai lo sappiamo da tempo – vuole la morte della Donna. Ma chi crede non dispera di chiedere la grazia all’unico Sovrano che può liberarci da queste insoffribili catene. Non mi faccio troppe illusioni sui ritrovati della tecnica o della medicina, perché per come la vedo io, essi non avranno il potere di liberarci realmente, ma solo Lui può farlo, se solo confidassimo stavolta, e con tutte le nostre forze, in un Monarca più illuminato del re Borbone. Illuminato e che illumina. E che salva”.