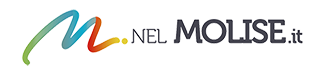LARINO. Questa volta, l’amico Pino Miscione in occasione del mese dedicato ai defunti, ci fa fare un viaggio nel tempo per descrivere due sepolture diverse, la prima, risalente ai fasti della Larino romana, di una donna Didia Decuma, l’altra di un defunto di oggi che attende ancora una lapide. Una riflessione storica e profonda arricchita dalla citazione del grande Principe Totò.
Didia Decuma: chi era costei? Il suo nome è bellamente inciso sopra un antico, grosso frammento di pietra ben levigata e curvilinea, che a metà Quattrocento si pensò di murare, assieme ad altri ben tenuti resti, sopra uno dei due archi ad ogiva che reggono la torre campanaria della Cattedrale larinate dell’Assunta, opera del magister irpino Giovanni da Casalbore, ultimata da altri artefici ai primi del Cinquecento. Si mostrano ai passanti o ai visitatori forestieri che abbiano oltrepassato la poderosa arcata, per addentrarsi nei pittoreschi ed intricati vicoli di questa parte del centro storico medievale che va calando verso occidente, eleganti nelle loro decorazioni fatte di bucrani e maschere dai quali pendono nastri e ghirlande lemniscate, che fanno da ragguardevole corona alle uniche parole incise nella dura pietra: DIDIAE, BARBI FILIAE, DECUMAE OPPIANICA ET BILLIENA MATRI FECERUNT. A Didia Decuma, figlia di Barbo, Oppianica e Billiena fecero per la madre.
Questa donna apparteneva all’antica gens Didia, che si crede originaria di Larinum ovvero della prossima città frentana di Histonium, l’odierna Vasto. Una famiglia assai altolocata, che gode di un’ininterrotta presenza nelle iscrizioni larinati conosciute, che vanno dal I secolo a.C. al II d.C. Alla sua morte, avvenuta qualche decade prima dell’avvento di Cristo, le sue due figlie, Oppianica e Billiena, commissionarono una tomba in memoria della madre defunta, vedremo di che tipo.
Alla gens Didia apparteneva anche Aulus Didius, citato nel famoso senatoconsulto del 19 d.C. rinvenuto a Larino nel 1970, che a Roma raggiunse la carica di questore. Qualche studioso arriva ad identificarlo con A. Didius Gallus che divenne console nel 39 d.C., elevando ulteriormente il profilo degli aristocratici larinati all’interno dell’élite che governava l’Impero. Nel secolo successivo, ritroviamo invece questa antica famiglia esclusivamente nel governo della cosa pubblica della sua città di origine. Il buio andito dello scalone del Palazzo Ducale mostra ancora oggi, cementata nella parete, la stele funeraria di un’altra donna appartenente a questa distinta casata, Didia Maxima, morta giovanissima all’età di 18 anni nei primi secoli cristiani.
Appoggiandoci ad altri esempi consimili presenti in altre località, tra le quali la prossima Sepino, dove a poche decine di metri della porta di Benevento, lungo il tratturo, era il mausoleo di Gaio Ennio Marso, o la più lontana Roma, che al terzo miglio della Via Appia mostra ancor oggi la più nota tomba di Cecilia Metella, potremmo immaginare come fosse la sontuosa sepoltura della matrona frentana Didia Decuma, eretta verosimilmente lungo una delle strade che dall’antico abitato romano di Larinum si ramificavano fino a toccare le città circostanti: costituita da un tamburo cilindrico del diametro di 5 o 6 metri, eretto sopra un basamento quadrangolare, che a mezza altezza mostrava la lapide col nome e il gentilizio della facoltosa estinta. Tipologia di monumento sepolcrale di derivazione ellenistica – circolare era anche il mausoleo di Alessandro Magno ad Alessandria –, riproposta pure nelle tombe a tumulo etrusche, quindi replicata in sepolture molto più elaborate, come quella dell’imperatore Augusto recentemente restaurata.
Alla ricca Didia Decuma l’onore di veder riconosciuto, dopo tanti secoli, il proprio nome riproposto addirittura sopra il prospetto posteriore del campanile di una splendida Cattedrale. Disperse oramai le sue ossa, o tumulate in qualche angolo recondito e ignorato, che attendono anch’esse l’Ultimo giorno, seppure in vita quel corpo non abbia fatto in tempo ad ascoltare la Buona Novella di Cristo. Non sappiamo in quale luogo ultraterreno si ricongiungerà la sua anima con la sua carne, a dispetto di quel che dicono di solito certi preti alla moda dai loro amboni: «È tornato alla Casa del Padre». Stando al Catechismo che conosco io, non è detto che vada a finire sempre e inequivocabilmente in questo modo.
Andar nei camposanti ad elevar preci per i morti è opera di misericordia alla quale il buon cristiano è chiamato, soprattutto in questo mese di Novembre che principia, benché pratica desueta e ultimamente assai contrastata per via delle limitazioni imposte per causa del morbo infettivo. In questo cimitero cittadino, che il sindaco Giuseppe Bucci volle edificare dopo l’epidemia di colera del 1836 – fino all’editto napoleonico di Saint-Cloud i morti erano seppelliti solitamente nei sotterranei delle chiese – riposano anche quei non molti che hanno cessato di vivere perché da esso aggrediti mortalmente. Mi aggiro perciò, carico dei miei ricordi di oltre mezzo secolo di vita, tra le tombe dei miei defunti. Stanno sparpagliati qua e là, come capita per molte famiglie, credo; ed io li raggiungo scendendo e risalendo le scale piranesiane che si diramano in ogni direzione di questo camposanto adagiato lungo il declivio del Montarone che guarda a levante la mole colossale del promontorio garganico e la distesa erbosa del Tavoliere, fino alla metà dello scorso secolo percorsa dai pellegrini diretti alla Grotta dell’Arcangelo o all’Incoronata di Foggia. Defunti onorati dalla presenza in mezzo a loro della Cappella dedicata a colui che, in odium fidei, versò il proprio sangue.
Venendo giù verso il muro di cinta che costeggia la strada, giungo al tumulo spoglio di fiori ed ammantato di sola erba selvatica, sopra il quale sta infissa una cruciforme targa di plastica consumata dal sole, che scolorita ricorda timidamente il nome dell’estinto al passante affaccendato nella pietosa visita. Nessuno ha provveduto a dare un solido cippo di pietra a quest’uomo trapassato da me inconosciuto in vita, e sono trascorsi oramai già quattro anni dalla data del decesso; la sua famiglia poverissima o forse dispersa in altre località lontane. Tra un po’ nessuno potrà nemmeno più leggere a chi appartiene questo tumulo di terra che ricopre le sue ossa all’ombra dei cipressi: urna senza conforto di pianto dove il sonno della morte è ancor più duro; il suo nome lavato via dalla pioggia d’autunno, come un milite ignoto qualsiasi, quantunque disarmato e inoffensivo anche in vita, che ha combattuto la buona battaglia della sua esistenza, terminando la sua corsa che stando alla data di nascita non è stata lunghissima. Quali onori postumi abbia ricevuto per la sua militanza e quali corone di vittoria gli verranno consegnate, ignoriamo completamente. Ci appare solo manifesto che per lui non c’è stata l’onoranza di una lastra di pietra, come la nobildonna frentana Didia Decuma, che ricorda ai posteri di molti secoli dopo come si chiamava quando era tra i viventi. Anche per lui una preghiera di suffragio, di cui beneficerà in ogni caso qualche anima purgante.
Quale diverso destino terreno per i due morti! Mi viene da sorridere volgendo la mente al fatto che la distanza fra le due tombe, la quale riflette le diverse epoche d’inumazione, ha impedito che i due soggetti venissero a contesa a cagione del così tanto difforme trattamento ricevuto post mortem, com’è raccontato nella celeberrima poesia composta dal grande comico napoletano, che lui stesso amava recitare spesso in pubblico:
«’A morte ’o ssaje ched’è? … è una livella.
’Nu rre, ’nu maggistrato, ’nu grand’ommo,
trasenno stu canciello ha fatt’o punto
c’ha perzo tutto, ’a vita e pure ’o nomme:
tu nu t’hè fatto ancora chistu cunto?».
Annotazione che sarebbe rassicurante, se non fosse che certe innaturali divisioni vanno invece ora producendosi piuttosto tra i vivi, come in questi nostri giorni nei quali siamo arrivati addirittura all’assurdità infernale di vederli marchiati per venire separati in due categorie, col dissimulato intento di metterli gli uni contro gli altri: un giudizio tutto terreno, completamente umano, che forse definire tale sarebbe inappropriato vista l’intenzione contraria all’uomo, che anzitempo e impropriamente vorrebbe separare pecore e capri, eletti e reprobi, sostituendosi all’unico Giudice che conta. E chi cade nella trappola, chi cede alle passioni viscerali scaraventando nella contesa verbale la propria aggressività e prepotenza in faccia all’avversario, imbarbarendo così il dibattito e in qualche modo anticipando un clima d’odio che parrebbe preludere a qualcosa di molto peggio, non fa che accreditare una normalità che a rigor di legge naturale non potrà mai sussistere. A mio modo di vedere, era esattamente questo il proponimento di chi ha escogitato questo strumento di controllo sociale: dare in pasto alla folla qualcuno da odiare, allontanando da sé ogni responsabilità.
«’A morte è una livella». Questa nostra vita somiglia invece sempre più a un regolo che segna un inarrestabile e travolgente piano inclinato, che indica una discesa avente un inizio ma è incapace di marcare una fine ben determinata, lungo il quale scivola senza trovar barriere l’intrico di pubblico panico e speculazione politica, ed aumenta fino al parossismo la velocità degli eventi che divengono infine incontrollabili – è una legge fisica –, mentre a non pochi sembra di trovarsi tutt’al più in una orizzontalità completamente nuova, alla quale occorra adeguarsi per poter stare in piedi, senza porsi troppe questioni di ordine “geometrico”.
Immerso in questi pensieri intrisi d’inquietudine e di preoccupazione per l’avvenire, supero e lascio alle mie spalle il grande cancello di ferro antico che rinchiude nei loro sepolcri i morti larinesi. Torno alla città dei vivi, dove ogni giorno che passa sembra caricarsi d’un peso che sfianca chi lo porta. E mentre vado via lungo la strada incipressata, mi par di udire la voce del defunto prossimo all’anonimato per via della sua lapide precaria, che forse con l’intenzione d’infondermi un po’ di coraggio mi sussurra nell’orecchio il finale di quella poesia arcinota espresso nella lingua della città di Partenope:
«Sti ppagliacciate e ffanno sulo ’e vive:
nuje simmo serie… appartenimmo â morte!»