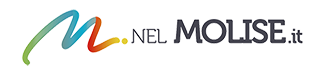LARINO. La nostra pagina culturale si arricchisce oggi del qualificato intervento storico dello studioso frentano Pino Miscione che dal passato riporta al presente la figura di Marco Tullio Cicerone. L’arpinate, fu politico, scrittore, oratore, filosofo ed avvocato romano. E proprio in questa sua ultima veste ha legato la sua professione anche alla città frentana. L’arringa in difesa del larinese Aulo Cluentio Habito, tenuta da Cicerone, quarantenne, nel 66 a.C. dinanzi al tribunale penale competente per i crimini di veneficio è tra le più lunghe e complesse orazioni ciceroniane pervenuteci.
L’intervento di Miscione rievocando la suddetta orazione, ci riporta al presente lanciando la proposta all’amministrazione frentana di dedicare un monumento all’Arpinate che vincendo la causa ‘ha consentito all’antica Larino romana di rimanere in perpetuo nella storia della letteratura latina’.

“Il 7 dicembre del 43 a.C., sicari inviati da Antonio, uno dei triumviri, raggiungevano Marco Tullio Cicerone nella sua precipitosa ed inutile fuga di villa in villa, fino all’ultima statio di Formia. Braccato, si arrendeva agli sgherri ordinando ai suoi servi di deporre la lettiga che lo trasportava, e il ferro affondò inesorabile nel suo collo pingue offerto ai carnefici. Per ordine espresso di Antonio, le sue mani che avevano messo per iscritto le Filippiche che severamente lo accusavano vennero mozzate ed infisse come la sua testa a pochi passi dal Senato, ad ammonimento degli oppositori.
In questo modo tragico – era poco più che sessantenne – finiva la vita di uno dei più grandi prosatori latini, dei più eloquenti oratori, dei più capaci avvocati del foro. Era stato giovane questore in Sicilia, edile curule, pretore, e finalmente console, la massima magistratura dello Stato; quindi costretto all’esilio, ma poi di nuovo àugure e proconsole in Cilicia; successivamente il ritiro dalla vita pubblica in contrasto con Cesare, e di nuovo sulla breccia dopo l’assassinio di lui alle Idi di marzo del 44. Inimicatosi Antonio, la fine.
Una delle sue opere più riuscite, che egli scrisse nell’ultimo scorcio della sua vita non lunghissima, fu il Catone Maggiore, della vecchiezza. In questo tempo nostro dove la vita umana, specie delle generazioni più attempate, è così tanto spesso a rischio, suonano cariche di speranza quelle massime da lui composte per questo intimo libello dal contenuto filosofico: Nemo est tam senex qui se annum non putet posse vivere, “Nessuno è tanto vecchio che non creda di poter vivere ancora un anno”. Ancora un anno, perché la vita vive e non teme la morte. Ciò è vero anche in questa nostra città dove in diversi ci hanno lasciati, in questa Larino che Cicerone visitò più volte nella prima parte della sua trentennale carriera. Aveva allora quarant’anni ed era stato il più eletto degli otto pretori. Aspirando al consolato che avrebbe ottenuto tre anni dopo, lui homo novus e provinciale, era consapevole di doversi appoggiare ad influenti amicizie per ascendere ai più alti gradi dello Stato. Accettò la difesa di una personalità che apparteneva al suo rango, il cavaliere larinate Aulo Cluenzio Abito – membro della gens che Virgilio fece poi discendere da Cloanto, compagno di Enea –, proprio perché gli equites di Larinum gli avrebbero potuto procurare sostegni utili alla sua carriera, che lui si augurava rapida e brillante.

I fatti sono piuttosto noti, ma li ridiciamo: Cluenzio era un personaggio in vista dell’establishment della città che solo pochi decenni prima, alla conclusione della Guerra sociale, aveva ottenuto lo status di municipio, e ai suoi abitanti era stata perciò estesa la cittadinanza romana. Non così invece per la cospicua comunità dei Marziali, servi votati al dio della guerra, atavico culto del territorio larinate, ai quali l’antagonista di Cluenzio, Stazio Abbio Oppianico, peraltro suo patrigno, salito al potere col terrore sillano nell’82 a.C., voleva concedere proprio quell’ambita cittadinanza oltreché la piena libertà, probabilmente per accrescere la propria clientela politica: una sorta di ius soli dell’epoca. Questo fu il casus belli che, tra tentativi di avvelenamento incrociati, sarebbe culminato nella morte per veleno di Oppianico nel 72 a.C. assunto, con certa audacia da chi ve lo mise, in un boccone di pane.
Declinava allora, come per molti versi pure in questo nostro tempo, la Repubblica; dilaniata dai contrasti fra le opposte fazioni: mariani e sillani dapprima, pompeiani e cesariani poi, seguaci di Antonio e di Ottaviano infine: è la storia antica del mondo che si perpetua singultando fino ai giorni nostri. Repubblica sopraffatta sì da rivalità personali, ma ancor più dalla degradazione dei costumi che dilagava nelle classi più alte, mentre la plebe attonita, quando non degradata anch’essa, si rifugiava confidente nel culto dei padri. Culto pagano, però; perché, come si è detto, a Larino il culto più fiorente, quello ufficiale della città, era quello tributato a Marte. I calendari festivi che ci sono noti, specie quello molto più tardo di Filocalo inciso nel marmo nel 354 d.C. che elencava feste molto più remote, ci riportano che nel medio tempo di maggio si festeggiava quel dio bellicoso con corse di aurighi nei circhi e ludi gladiatorii negli anfiteatri: era ancora di là da venire il credo cristiano, che solo grazie al sangue versato da alcuni figli di questa nostra terra avrebbe vinto quei riti idolatrici, quando non empi: è questa la ragione, in fondo, per la quale i nostri Martiri sono festeggiati in quella medesima data. Ma questa forse è un’altra storia, della quale ho parlato più approfonditamente nel mio libro Larino micaelica.
Nondimeno, in quell’ultimo secolo antecedente all’avvento del Dio cristiano fattosi carne, in questa nostra città avvennero fatti di incredibile crudeltà e dissolutezza che Cicerone ci restituisce nel dettaglio: una successione impressionante di assassinii, aborti procurati, falsificazioni di lasciti per accaparrarsi le fortune assegnate ai legittimi beneficiari. Abile com’era, sfruttando quella che dai retori è definita apoplànesis, cioè la capacità di distogliere l’attenzione dall’oggetto vero del processo per indirizzarla altrove, Cicerone ci riporta quel che a suo dire commise la parte offesa, rappresentata in giudizio da un legale pesarese. Stando a lui, Oppianico si sarebbe macchiato dei seguenti crimini:
fece innanzitutto uccidere il cognato Marco Aurio, ridotto in schiavitù; proscrisse, come quattuorvir di parte sillana, Aulo Aurio Melino, che lo aveva incolpato del delitto, di cui avrebbe poi sposato la moglie Sassia. Per poterlo fare, era arrivato ad eliminare due suoi figli piccoli, avuti da precedenti mogli. Ma prima ne aveva avvelenata un’altra, Cluenzia, e sempre per accaparrarsi le fortune altrui, il proprio fratello Caio Oppianico e sua moglie Auria, e con lei il figlio che portava in grembo. Aveva fatto assassinare a Roma il giovane larinate Asuvio, dopo averne alterato il testamento e fatto sigillare un altro mediante una sostituzione di persona; per farla franca aveva corrotto il triumviro Quinto Manlio. E ancora: si era accordato con la vedova del cognato Magio per farla abortire e infine sposarla – ebbe in tutto sei mogli –; si era servito di un guaritore ambulante, distributore di strane pozioni, per avvelenare la suocera Dinea, di cui pure aveva falsificato il lascito; aveva poi manomesso i registri ufficiali del censimento della città, tentato l’avvelenamento del rivale Aulo Cluenzio e, per finire, corrotto i giudici nel processo che lo riguardava.
Ricordata questa interminabile lista di misfatti attribuiti alla parte soccombente, non resta da dire che il colpevole Cluenzio, grazie all’abilità del suo avvocato, venne assolto. Quintiliano, nella Institutio oratoria, riporta in effetti che Cicerone, il quale riteneva “esemplare” questa sua più lunga orazione, in qualche lettera a noi non pervenuta si era vantato di aver ottenebrato la mente dei giudici.

Legum omnes servi sumus ut liberi esse possimus, “delle leggi tutti siamo schiavi perché possiamo essere liberi”. Frase ad effetto pronunciata da Cicerone davanti a quegli stessi giudici romani che dovevano deliberare su quel caso di avvelenamento. Massima che ritroviamo in tanti testi di diritto romano, quando non ripetuta all’interno delle aule dei tribunali di questa nostra malconcia Repubblica. Essa mi pare faccia un buo paio con quest’altra che ho riscovato tra le mie carte ingiallite: bonus civis est qui non potest pati eam in sua civitate potentiam quæ supra leges esse velit, “il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d’essere superiore alle leggi” (Epistulæ ad Brutum). Ma ci sarebbe forse da chiedersi: e se le leggi sono palesemente inique, se infrangono il diritto naturale, come ci si deve regolare? E se esse poi contraddicono altre leggi di rango superiore, come? E quando è perfino la legge massima dello Stato ad essere scavalcata o aggirata, non pochi giuristi fanno osservare che il vulnus che ne viene risulterà inevitabilmente fatale.
Nati sumus ad congregationem hominum et ad societatem comunitatemque generis humani, “Noi siamo nati per unirci con i nostri simili, e per stare in comunità con la razza umana”. È una legge eterna connaturata all’uomo, da Cicerone messa per iscritto diversi anno dopo la Pro Cluentio, nel de Legibus. In questi mesi nei quali vigono ancora i provvedimenti reiterati dal nuovo governo repubblicano, a molti essa sembra messa in discussione. Come altrettanto contestate appaiono altre espressioni che la sua mente sagacissima lasciò a noi posteri: libertas non in eo est ut iusto utemur domino, sed ut nullo, “la libertà non consiste nell’avere un padrone giusto, ma nel non averne alcuno” (de Re publica); e per finire, riprendendo Platone, scientia, quæ est remota ab iustitia calliditas potius quam sapientia est appellanda “la scienza, quando si allontana dalla giustizia merita di essere chiamata malizia, piuttosto che sapienza” (de Officiis).
Senza volermi inoltrare più del necessario in diatribe che tuttora feriscono le coscienze di molti, riporto queste omologhe sentenze così come le ho trovate nei miei libri impolverati e nei miei annosi appunti. Ognuno tragga quel che ritiene più opportuno da queste massime. Non è certamente questa la sede adatta per aprire dibattimenti, quantunque io sia convinto che i grandi spiriti come Cicerone, che pagò con la vita la strenua difesa della Repubblica, sono nati e vissuti anche per scuotere dal letargo troppe menti intorpidite.

Meditando sulla tragica fine del filosofo e uomo di Stato, così conclude nel suo saggio storico Momenti fatali lo scrittore austriaco Stefan Zweig (1881-1942), che dedica a Cicerone la penultima delle sue miniature: «Nessuna invettiva contro la brutalità, l’illegalità e la smania di potere proferita dal grande oratore su questa tribuna ha mai denunciato in modo così eloquente il male eterno della violenza quanto il linguaggio muto del suo capo profanato: il popolo si avvicina timidamente ai rostra, poi con un senso di vergogna e costernazione se ne allontana. Nessuno dei presenti osa protestare – siamo in una dittatura! –, ma angosciati, col cuore stretto in una morsa, abbassano lo sguardo davanti al tragico simbolo della loro Repubblica crocifissa».
Ma per più modestamente concludere pro domo mea, una laica prece alle autorità larinesi mi sento d’inoltrare: nel reticolo di strade della toponomastica cittadina compare pure una via Cicerone, che è una stradina a senso unico calante dal fianco della chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine delle Grazie, dove peraltro sono nato. A parer mio davvero troppo poca cosa per onorare un gigante del pensiero e della storia universale com’è lui. Da questa pagina web, mi rivolgo dunque a chi ha una qualche voce in capitolo: erigete un degno monumento in prossimità del Palazzo di Giustizia, prima che venga soppresso pure quello, a colui che ha consentito all’antica Larino romana di rimanere in perpetuo nella storia della letteratura latina, anche se ne racconta la vita dissoluta. Opportuno, credo, che v’incidiate alla base quella sua solenne massima: legum omnes servi sumus ut liberi esse possimus. Ma liberi davvero.
Per intanto, ai Larinesi in apprensione per il morbo, dico: “finché c’è vita, c’è speranza”. Anche queste – forse non lo si sa affatto – sono parole sue che nel sermo latino suonano dum spiro, spero (Epistulæ ad Atticum). Speriamo”.
Pino Miscione
(foto ed elaborazioni fotografiche dello stesso autore)