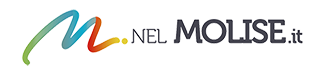Quarta lettera “dall’esilio” del Vescovo Gianfranco De Luca alla comunità in tempo di emergenza coronavirus e di sospensione delle attività pastorali.
In questo tempo di esilio, prepotente, senza nessuna delicatezza, è riemersa, imponendosi, la realtà della Morte. Da qualche giorno ha un spazio rilevante ed evidente sulle prime pagine di ogni giornale, ma soprattutto occupa la mente e turba il cuore di ciascuno di noi. Risulta quasi una novità, anche se tale non è, anzi; ma attraverso il tam-tam dei resoconti quotidiani , la impossibilità della celebrazione di riti religiosi, e la restrizione quasi totale delle altre manifestazioni di cordoglio e di vicinanza a quanti da essa vengono colpiti, la morte si presenta in tutta la sua ineluttabilità e la sua durezza, verrebbe da dire, crudeltà. E’ come il risveglio brusco da un sogno: in realtà nella nostra società in preda alla frenesia del lavoro e impegnata nella ricerca del benessere, e nel migliorare la qualità della vita, non c’è posto per il pensiero della morte. Anzi abbiamo cercato di emarginarla, quasi a volerla esorcizzare. La parola morte viene aggirata, diciamo: “fine della vita”, “ conclusione del cammino terreno” “uscita dalla scena dalla storia”, “decesso”; e, relativamente al morto, parliamo di lui come di colui che “non è più”, di chi “si è spento”, di chi “è mancato”. La stessa esperienza della morte, in qualche modo, viene messa in sordina: accade il più delle volte fuori casa, in ospedale, nella casa di cura; la si cela, a volte, ai nipoti con la motivazione di non farli soffrire.Il lutto, poi, è tutto vissuto nel privato, senza segni esterni, sembra che non abbia diritto di evidenza in una società costruita e vissuta secondo il trinomio salute, giovinezza, felicità. Si potrebbe dire che si esige dal “moribondo” uno stile consono, quello che alcuni sociologi chiamano “dolce morte dell’uomo di massa”, grazie al quale si esce di scena in silenzio, senza procurare un disturbo eccessivo e turbamenti troppo grandi.

L’ approccio medico al dolore e alla morte, si riduce e viene affrontato come un problema tecnico. Si deve solo mettere in atto le cosiddette “tecniche dell’apatia”, che hanno la funzione di ritardare il momento del trapasso o di farlo accettare senza eccessiva angoscia. La morte è ridotta ad un evento biologico da subire passivamente. Il riproporsi della realtà della morte, in questo tempo di coronavirus, è brusco, e sconvolgente, e sicuramente induce a pensare. Mette dinanzi alla domanda fondamentale: che senso ha la mia vita? E’ un interrogativo che ne pone altri: “da dove vengo” e “dove vado”? … La morte, quella mia, è il caso serio della mia vita e finché non ne comprendo il senso cammino nel buio. Se la morte è la fine di tutto, siccome è certo che moriremo, allora la vita, in fondo, non ha un gran senso, e anche quello che in essa sembra aver senso si spegne, si vanifica nella morte che ci attende. La coerenza ci porterebbe a dire: se sono destinato al nulla, tanto vale anticiparlo. Pur se logico e stingente, questo ragionamento, non risponde a quanto vive dentro ciascuno di noi: un desiderio di felicità e di vita che ci fa intuire che quel ragionamento non può essere vero. Ritengo che, quando quel desiderio si inaridisce e si spegne, allora prevale il ragionamento con la sua logica stringente. E’ il cuore avvolto da tenebre, avvertite definitive; e viene da precipitarsi dentro di esse. Quanta tristezza e quanta angoscia dinanzi ad amici e ad amiche che si sono calati, attirati, in quel baratro! Proprio domenica scorsa, 28 marzo, nella liturgia della Parola ci veniva fatto un annuncio: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, … L’ho detto e lo farò».(Ez 37,12-14), e nel Vangelo abbiamo letto il racconto della risurrezione di Lazzaro narrata da Giovanni (cap.11). Se la promessa dell’apertura dei sepolcri e della conseguente non definitività della morte, risponde a quanto vive nel cuore di ognuno di noi, il racconto del vangelo mi dice concretamente come questo può diventare per me esperienza e risignificare tutta la mia esistenza già da adesso. La rianimazione di Lazzaro che Gesù opera è il segno di una realtà più grande e per tutti, in Lui e grazie a Lui, la morte non è la parola ultima, ma penultima, della nostra esistenza; è la vita in pienezza, la parola definitiva, infatti Lui è la risurrezione e la vita e chi crede in lui anche se muore vivrà.
Carissimi, Gesù non ci salva dalla morte, l’ha vissuta, drammatica e ignominiosa, anche Lui: è morto tra malfattori come un maledetto da Dio. Qui è necessario che noi ci liberiamo da un’idea di dio, solo ed esclusivamente umana: come colui che, onnipotente, interviene per toglierci dai guai, fa miracoli per liberarci dalla malattia, e, in fondo, stabilisce, a suo piacimento, la nostra sorte e quella dell’umanità. Così in questi giorni di pandemia, come in altri momenti tragici della nostra storia personale e collettiva, rispunta questa domanda, ma “Dio dov’è? Si ripete la scena del calvario: dove sia i soldati, sia i capi del popolo, invitavano Gesù a scendere dalla croce per mostrare il suo essere Dio. Gesù ci salva nella morte. Certamente è dell’uomo essere mortale. Gesù, Dio fatto uomo, ha fatto suo ciò che è pienamente ed esclusivamente nostro, il limite, la morte. Questo perché ci ama. E’ l’unico modo reale per amarci, perché l’amore assume, condivide e trasforma, e non può trasformare quello che non assume e condivide. Lì sulla Croce accade e si compie tutto questo: fermati un momento a guardare il Crocifisso: contempla, prega, ringrazia. Gesù ci fa scoprire che il nostro limite, la nostra morte, non è il luogo dello scacco, ma il luogo della comunione, della relazione con Lui e tra noi. Lì, nella morte, nel limite, Gesù si è fatto nostro compagno; ci offre la sua amicizia e ci dà la possibilità di entrare in comunione con Lui che è la Vita. La vita di fede è questa amicizia accolta e vissuta. E’ molto di più di sapere e confessare che c’è la vita eterna e la risurrezione dei morti, come ogni domenica facciamo recitando il Credo. E’ accogliere Gesù in noi, attraverso la Parola e i sacramenti, entrare in comunione con il Padre, poter vivere ogni situazione della vita da figli amati, e relazionarci con gli altri da fratelli. Vivere in Gesù è già vivere una vita che ha vinto la morte. San Giovanni nella sua prima lettera testimonia: “Noi siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli.” Viene così in evidenza che il problema non è la morte, ma che è importante come viviamo la morte e la vita. Se è vero che ognuno nasce da una madre, la morte ci fa scoprire di avere un Padre. Nel mio cuore, anche nell’angoscia e nella tristezza che mi hanno afferrato, dinanzi al precipitare, attratti nel baratro del nulla, di amici e amiche, sono certo che laggiù li aspettava Gesù. Lui, crocifisso, morto e sepolto, è disceso nel baratro del nulla: nessuno è e sarà solo e ognuno Lo trova compagno. E Gesù, quando l’incontri, ti rivela il Padre. Carissimi, la vita è bella non a tratti, non a sprazzi, ma sempre, così com’è!
Gioie e dolori, speranze, sogni raggiunti. Maturità di vita e di pensiero. Solidità. Senso del dovere e richiamo d’amore dall’Alto, cui risponde la coerenza della nostra vita. Fatiche. Fiamme e conquiste. Temporali. Fiducia in Dio: Dio solo. Su. Giù. Piogge tempestose, radici profonde. Frutti, frutti, frutti… Annebbiamento dell’anima: «Dio mio, Dio mio…». Poi, musica soave di Cielo, lontana. Poi più vicina. Rullo di tamburi: vittoria! Lunga la vita, varia la strada, vicina la mèta. Tutto, ogni cosa, sempre, ha, ha avuto, un solo destino: l’unione con Te.
Vostro nel Signore + Gianfranco vescovo